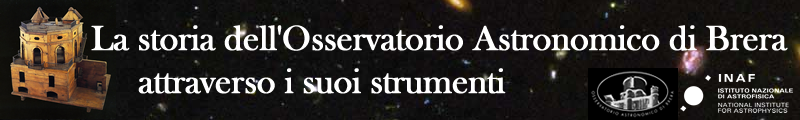-- Home page --
La nuova sede di Merate
Le condizioni osservative di Brera stavano rapidamente peggiorando a causa del diffondersi dell’illuminazione
pubblica, tanto che già dal 1838 Francesco Carlini, allora direttore dell’Osservatorio, si era posto il problema di trovare una nuova sede al di fuori della città; alla fine del secolo Schiaparelli
si lamentava del fatto che non era più possibile effettuare le osservazioni con la stessa precisione
di vent’anni prima: «Certo è che la città, in mezzo alla quale la Specola si trova, si estende rapidamente
da tutte le parti; il fumo del carbone rende l’atmosfera sempre più opaca, e l’abuso della luce
elettrica comincia a toglier molto dell’oscurità della notte» (Cronaca della Specola di Brera, 1893).
Finalmente Emilio Bianchi, direttore dell’Osservatorio dal 1922, ottenne come nuova sede villa San
Rocco a Merate (un paese della Brianza a circa 30 km a nordest
di Milano), una struttura che era
stata adibita a ospedale durante la Prima Guerra Mondiale e che era allora inutilizzata.
Dopo i necessari
lavori di adattamento, nel 1926 venne installato a Merate un nuovo telescopio, un riflettore
Zeiss che l’Italia aveva ottenuto dalla Germania in conto di riparazione dei danni di guerra per la
Prima Guerra Mondiale, secondo il dettato del trattato di Versailles.

Telescopio riflettore Zeiss (1926).
L’obiettivo del telescopio è costituito da uno specchio di 102 cm
di diametro e 5 m di lunghezza focale (rapporto focale f/5).
Il telescopio può essere utilizzato sia in
configurazione newtoniana18 che in configurazione Cassegrain19: in questo caso la lunghezza focale
effettiva risulta di 16 m e il rapporto focale f/16 (Figura 29).
Il telescopio era dotato di un telescopio di guida20 da 20 cm di apertura e 3 m di lunghezza focale, di due cercatori21, di una serie di oculari e
di due spettrografi (Figura 30).

Il confronto tra questo strumento (che allora era il più grande in Europa)
e quelli usati all’epoca di Boscovich evidenzia con chiarezza il cambiamento di interessi della
ricerca astronomica nel corso del secolo e mezzo trascorso, dall’astrometria (misura della posizione
dei corpi celesti) all’astrofisica (studio delle loro caratteristiche fisiche).
Le misurazioni astrofisiche
non richiedono un elevato numero di ingrandimenti22 ma di raccogliere la maggior quantità di luce
possibile, in modo da poterla facilmente analizzare con strumenti come fotometri o spettrografi23: la
caratteristica più importante di un telescopio quindi non è più la sua lunghezza focale ma il diametro
del suo obiettivo.
La crescita delle dimensioni dell’obiettivo dei telescopi ha poi portato all’abbandono
degli strumenti rifrattori (in cui l’obiettivo è costituito da una lente) a favore dei riflettori
(in cui l’obiettivo è uno specchio).
Infatti una lente di grande diametro, per avere la curvatura che le
permetta di focalizzare correttamente i raggi luminosi, deve necessariamente avere anche un grande
spessore, e ciò produce una forte attenuazione della luce a causa dell’assorbimento dovuto alla non
perfetta trasparenza del vetro; questo problema ovviamente non sussiste quando l’obiettivo è costituito
da uno specchio, che focalizza la luce per riflessione.
Inoltre è molto più facile reggere l’enorme
peso di questi grossi obiettivi nel caso di uno specchio, che può essere fissato alla montatura su
tutta la sua superficie posteriore, che nel caso di una lente, che ovviamente può essere sostenuta
solo lungo il suo bordo.
Di fatto gran parte degli strumenti con apertura superiore al mezzo metro
sono riflettori24.

A Merate vennero progressivamente trasportati alcuni degli strumenti di osservazione precedentemente
installati a Brera: ad esempio nel 1936 vi venne trasferito il rifrattore Merz-Repsold
da 49 cm, che fu utilizzato fino agli anni ’60.
L’attività osservativa della sede di Brera comunque non cessò del tutto: fino agli anni ’70 vi vennero effettuate regolarmente osservazioni dei transiti al meridiano
di stelle utilizzando strumenti dei passaggi (Figura 31), con lo scopo di determinare con precisione
il tempo siderale25, e osservazioni ottiche di satelliti artificiali.
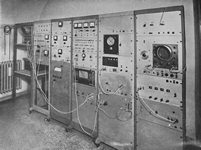
Le attività connesse con la misura
del tempo, oltre a essere necessarie per le osservazioni astronomiche e a permettere ricerche nel
campo della geofisica (ad esempio lo studio delle variazioni della velocità di rotazione terrestre26),
avevano anche un’importante ricaduta civile: per molti anni l’Osservatorio fornì, attraverso cavi elettrici
e ponti radio, i segnali di sincronismo che permettevano alla compagnia dei telefoni (SIP) e alla
radio di trasmettere i segnali orari.
L’Osservatorio aveva anche installato sul palazzo della Rinascente
in piazza del Duomo a Milano una sirena che, suonando tutti i giorni a mezzogiorno in punto,
permetteva ai passanti di sincronizzare i propri orologi.
Nel decennio 1960-70
fu attivo a Brera un
Centro di Cronometria (Figura 32), che aveva il compito di verificare e certificare la precisione dei
cronometri per uso scientifico e civile.
È questo un campo in cui la scienza interagisce fortemente
con lo sviluppo tecnologico, come è documentato dalla fitta rete di rapporti che l’Osservatorio intrattiene con il mondo industriale.