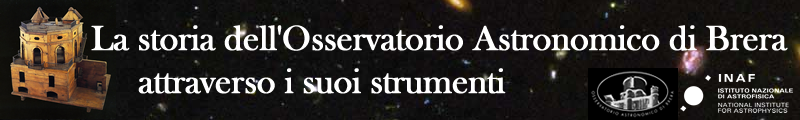-- Home page --

La specola di Boscovich
La Grange fu aiutato nella fondazione dell’Osservatorio da un altro padre gesuita, Ruggero Boscovich (1711 - 1787 - Figura 3), a cui nel 1764 era stata affidata la cattedra di matematica all’Università di Pavia (all’epoca l’unica università in Lombardia).

Probabilmente il Boscovich aveva visitato il Collegio di
Brera, aveva saputo dell’intenzione di fondare un osservatorio e si era appassionato all’idea; nel 1764
gli venne affidato ufficialmente il compito di preparare il progetto per il nuovo osservatorio (Figura 4).
Boscovich era una personalità scientifica di primo piano; la sua opera principale, la Philosophiae naturalis theoria (1758), una specie di enciclopedia di scienze naturali, è uno dei trattati scientifici più autorevoli
e più citati della seconda metà del XVIII secolo.
Boscovich era anche esperto in architettura
e ingegneria civile e in pochi mesi progettò e fece costruire i locali che dovevano ospitare il nuovo
osservatorio, alla sommità dell’angolo sudorientale
del Palazzo di Brera.
Esso era composto da due
piani: il piano inferiore era diviso in cinque stanze, che ospitavano i quadranti murali, gli orologi a
pendolo e altri strumenti; il piano superiore consisteva di un’unica stanza, di pianta ottagonale, ed
era usato per le osservazioni con i telescopi e per le lezioni dimostrative di astronomia per il pubblico6.
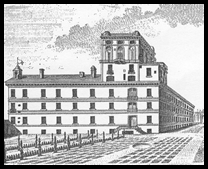
Sopra la stanza ottagonale si trovava una terrazza dotata di due cupole coniche. Il
risultato fu estremamente soddisfacente, tanto che nel 1776 il grande astronomo francese Lalande,
nel Journal des Savants, scriveva in termini elogiativi della nuova specola, augurandosi che se ne
pubblicasse una descrizione dettagliata a beneficio di tutti gli astronomi (Figura 5).
E più di un secolo dopo,
facendo la storia dei primi anni di attività dell’Osservatorio, Schiaparelli osservava: "Così in breve
tempo era sorto in Milano un Osservatorio, assai ben costituito".
In pochi anni l’Osservatorio di
Brera divenne la più importante istituzione astronomica in Italia>, dove si formavano come apprendisti
i migliori scienziati, che venivano poi assunti presso altri istituti7.
Questa situazione di predominio
scientifico durò almeno fino al primo ventennio dell’Ottocento8.
Per quasi un decennio La Grange e Boscovich si divisero il compito di dirigere la specola di Brera.
I due avevano caratteri e impostazioni scientifiche quasi opposte: Boscovich era eclettico e intraprendente
e aveva progetti ambiziosi per il futuro dell’Osservatorio; La Grange era molto più cauto, legato
a un mentalità scientifica più tradizionale, e preoccupato di contenere le spese per l’acquisto di
strumentazione.
In breve tra i due sorse un dissidio; nel 1772 Boscovich diede le dimissioni da tutti i
suoi incarichi e lasciò l’Osservatorio.
L’anno successivo (1773) l’ordine dei Gesuiti fu soppresso da
papa Clemente XIV; il Collegio di Brera, con l’annesso Osservatorio, venne statalizzato e passò sotto
le dirette dipendenze del governo austriaco a Milano.

Gli Austriaci dimostrarono subito un particolare
interesse per lo sviluppo dell’Osservatorio, dotandolo dei mezzi economici e del personale
necessari per proseguire nelle linee di sviluppo tracciate dal Boscovich; già nel 1773 essi fecero venire
appositamente da Vienna Joseph (Giuseppe) Megele, tecnico specializzato nella costruzione di
apparecchi ottici e meccanici, a cui si deve gran parte della nuova strumentazione costruita nell’Osservatorio
fino al 1816 (anno del suo pensionamento); nel 1775 giunse all’Osservatorio un nuovo
astronomo, Barnaba Oriani (Figura 6), che poco dopo ne assunse la direzione. Oriani era famoso a livello internazionale
soprattutto per i suoi lavori di meccanica celeste; a lui si devono il primo calcolo accurato
dell’orbita del pianeta Urano (scoperto nel 1781 da William Herschel) e la determinazione dell’orbita
del primo asteroide, Cerere, scoperto da Giuseppe Piazzi nel 1801.
Nel 1774, soddisfacendo un desiderio dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, l’
Osservatorio pubblicò il primo volume delle Ephemerides Astronomicae, un annuario astronomico che in breve divenne
famoso e apprezzato in tutto il mondo (su richiesta del cancelliere von Kaunitz, l’annuario venne redatto
in lingua latina per facilitarne l’utilizzo anche fuori dall’Italia).
L’annuario comprendeva due
sezioni: la prima era costituita da una serie di tabelle con le posizioni previste per il Sole, la Luna e i
pianeti, utilizzate dagli astronomi per le osservazioni; la seconda conteneva una raccolta di articoli
scientifici.
La pubblicazione dell’annuario continuò senza interruzioni per un secolo esatto, fino al
1874.