Curve di luce dei GRB
Il satellite della NASA Swift, frutto della collaborazione USA-UK-ITA, ha permesso di studiare
l’andamento nel tempo della luminosità (o curva di luce) delle esplosioni più misteriose e potenti
che si possano osservare in cielo: i lampi a raggi gamma (GRB).
Dalla loro scoperta, avvenuta nel 1967, fino ai primi anni novanta, si pensava che questi lampi
fossero caratterizzati da un’unica intensissima emissione di raggi gamma. Grazie al satellite italo-
olandese Beppo-Sax in orbita dal 1997 al 2002 si è scoperto invece che l’intera esplosione non si
esaurisce nella sola emissione di raggi gamma ma nell’arco di un mese è possibile osservare il
lampo anche in altre bande dello spettro elettromagnetico: nei raggi X, nell’ottico, nell’infrarosso e
infine nel radio.
Fino al 2004, anno in cui Swift viene messo in orbita, nell’osservazioni dei GRB aveva grande
importanza il “fattore umano”; avvistato un lampo gamma, solo il consenso della persona addetta
permetteva di far partire la campagna osservativa utilizzando i telescopi nello spazio e a terra.
Purtroppo le operazioni organizzative richiedevano alcune ore di preparazione e causavano un
ritardo nella raccolta dati.
Ritardo che solo l’innovazione tecnologica di Swift ha permesso di eliminare: la sua capacità di
allineare prontamente gli strumenti a bordo in direzione del lampo gamma e di comunicane le
coordinante celesti agli altri osservatori spaziali e terrestri ha permesso di eliminare questo gap
temporale.
E con le osservazioni del satellite sono arrivate le sorprese: la luminosità del lampo varia infatti nel
tempo in maniera diversa da quanto atteso. Invece della costante e continua diminuzione del flusso,
osservata fino ad allora, si è registrata una curva di luce irregolare con una caratteristica forma a
gradino: nelle prima fasi successive all’emissione gamma, il flusso diminuisce bruscamente per poi
stabilizzarsi e mantenersi costante prima di decrescere nuovamente in modo repentino.
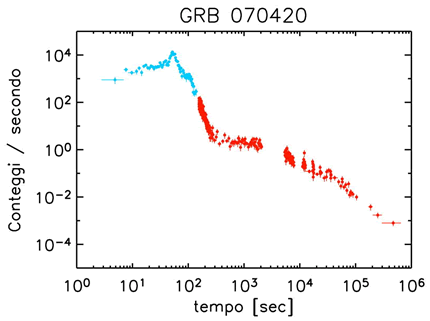
Curva di luce del GRB 070420 che evidenzia un andamento ripido - piatto - ripido
I ricercatori chiamano una curva di luce di questo tipo “ripido-piatto-ripido” (steep – flat – steep). La scoperta di una simile variazione del flusso ha notevolmente stupito i ricercatori in quanto il modello standard costruito sulla base delle precedenti osservazioni non è in grado di giustificare una curva di luce “a gradino”. Di particolare difficoltà è l’interpretazione fisica delle fasi di emissione in cui la curva di luce è piatta. Nell’ipotesi che GRB sia prodotto dall’atto di cannibalismo del buco nero che assorbe il disco trasformando la sua materia in energia, il gruppo di riceratori italiani dell’Osservatorio di Brera, Ghisellini, Ghirlanda, Tavecchio, Nava (una brillante studentessa di dottorato dell’Università di Como) e Firmani ritengono che una curva di luce di questo tipo si possa spiegare ammettendo che l’attività del buco nero si prolunghi per alcune ore dopo l’evento iniziale.
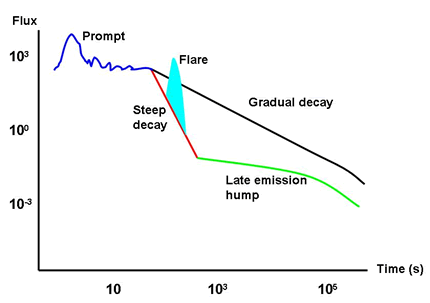
Curva di luce di un GRB caratterizzata dalla presenza di un flare.
Non solo, sempre nell’intervallo di tempo che va da un centinaio di secondi a qualche ora dopo il lampo, nella banda elettromagnetica dei raggi X si osservano dei picchi di emissione di diversa intensità chiamati “flares”. I ricercatori hanno dato diverse interpretazioni del fenomeno; una di queste è che si tratti di fenomeni di shock originati dallo scontro di materia con differente velocità. Ma ancora fitto è il mistero che avvolge queste esplosioni; solo lo studio dettagliato delle irregolarità nella curva di luce permetterà di costruire un modello teorico che sia il più rappresentativo possibile della realtà.
