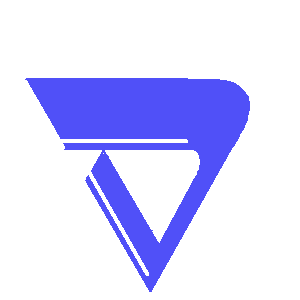 Il Sole
Finora hai visto il Sole come un corpo che agisce sui pianeti del Sistema Solare per mezzo della sua forza di gravità. Il Sole ha però un'altra peculiarità essenziale, quella di emettere luce propria. Nel Sistema Solare, il Sole è l'unico corpo con questa caratteristica. I pianeti riflettono semplicemente la sua luce. Potresti magari immaginare una stella lontana quanto Plutone. La sua distanza dal Sole è circa 40 volte quella della Terra. Visto da Plutone il Sole è dunque 40 volte più piccolo (come una moneta da 100 lire a 117 metri di distanza). Per la legge dell'inverso del quadrato, la luce del Sole che arriva su Plutone è meno di un millesimo di quella che arriva sulla Terra; ma è comunque quasi 40 milioni di volte maggiore della luce delle stelle più luminose! Sarebbe quindi difficile non vederla. L'immagine iniziale ti mostra chiaramente che il Sole emette luce propria. Hai anche scoperto che l'emissione di luce avviene a spese di una fonte di energia. Visto che il Sole se ne sta da solo, vuol dire che produce la propria luce consumando se stesso.
Questo filmato ti conferma che il Sole è un corpo gassoso caldo. Dalla superficie incandescente si levano fiamme di dimensioni comparabili con la distanza Terra-Luna. La massa del Sole è più di trecentomila volte quella della Terra. Il suo raggio è circa 100 volte quello della Terra. Come ricordi, la forza di gravità è proporzionale alla massa del corpo, e inversamente proporzionale alla distanza al quadrato. In pratica sulla superficie del Sole la forza è circa 28 volte più grande che sulla superficie della Terra. Una persona che sulla Terra pesa 70 chili vicino al Sole peserebbe quasi 2000 chili! Ovviamente non potrebbe sopravvivere, visto che la temperatura alla superficie è quasi di 6000 gradi! Visto che la massa del Sole è talmente grande, come mai non collassa su se stesso? Per rispondere, devi pensare a come è fatto un gas. Noi immaginiamo che i gas siano composti da un numero grandissimo di particelle invisibili. Per prima cosa solleva un po' il coperchio e metti in movimento le particelle. Clicca su poche particelle. Come vedi, il moto delle particelle è sufficiente a tenere sollevato il peso. Dopo aver messo in moto le particelle queste si agiteranno dentro la scatola sbattendo sulle pareti, sul coperchio e scontrandosi tra di loro. Se ti tirano molto forte un pallone tu vieni spinto indietro, e lo stesso accade al coperchio. Il coperchio tende a cadere, ma in ogni istante c'è un certo numero di particelle che sbattendo da sotto gli impedisce di muoversi. Prova ora ad aumentare la velocità delle particelle e poi il numero di particelle. Vedi cosa accade? L'effetto sul coperchio aumenta se aumenti la velocità, così come la spinta che ti dà il pallone è più forte se te lo tirano con una velocità maggiore. Se aumenti il numero di particelle il coperchio riceve un numero maggiore di colpi, quindi riceve una spinta verso l'alto più grande. Considera ora una porzione di superficie della scatola in una situazione di equilibrio. Cioè quando il coperchio galleggia mantenendo la sua posizione. Immagina che l'area della superficie sia costante. La superficie riceve allora, in un certo intervallo di tempo, lo stesso numero di colpi in qualunque posizione tu la consideri. Aumentando la superficie aumenta proporzionalmente anche il numero di colpi e quindi anche la forza media su di essa. La forza media su una superficie divisa per la sua area è quindi costante, e viene chiamata pressione. La pressione è dunque il risultato degli urti delle particelle del gas sulle pareti e sul coperchio, ed è tanto più forte quanto più le particelle si agitano e quanto maggiore è il loro numero. La temperatura di un gas è direttamente legata allo stato di agitazione delle particelle. Allora si può anche dire che per aumentare la pressione dentro la scatola si deve aumentare la temperatura del gas (cioè lo stato di agitazione delle particelle) o si deve introdurre altro gas (cioè aumentare il loro numero). Dopo averle messe in moto, le particelle continuano a muoversi perché, come hai visto in precedenza, i corpi tendono a rimanere in moto se non vi sono impedimenti. Per avviarle tu hai speso dell'energia. Per esempio, potresti averle colpite una per una. L'energia che tu hai speso è ora posseduta da loro, dunque puoi anche dire che le particelle tendono a conservare la loro energia. Ma anche la scatola non è un oggetto immaginario. Anche la scatola è fatta di particelle invisibili. Non sono libere come quelle del gas, ma anch'esse si agitano. Negli urti con le particelle della scatola le particelle di gas danno loro energia come tu l'hai data a loro all'inizio. In un urto è possibile che la particella di gas perda velocità e che la particella della scatola inizi ad agitarsi di più. Dunque la scatola aumenta la propria temperatura mentre le particelle del gas si muovono sempre meno e il peso pian piano scende. Il processo si arresta quando le particelle della scatola si agitano quanto quelle del gas, perché allora gli urti dove il gas scalda la scatola sono compensati da quelli dove la scatola scalda il gas. Si arresta quindi quando la scatola e il gas hanno la stessa temperatura. Dunque parte dell'energia che tu hai dato alle particelle del gas passa alle particelle della scatola. L'energia si trasferisce ma in totale si conserva. Come le particelle del gas agitandosi sorreggono il peso sopra il coperchio, così il Sole non collassa perché il gas di cui è fatto sorregge il proprio peso grazie alla pressione. Quanto maggiore è il peso da sorreggere tanto maggiore deve essere la pressione richiesta. Andando verso il centro del Sole gli strati di gas da sostenere sono sempre maggiori e sempre più pesanti, quindi la pressione aumenta via via fino a raggiungere valori elevatissimi. E di conseguenza anche la temperatura al centro sarà molto maggiore di quella alla superficie. Si può calcolare che la temperatura nel centro del Sole è attorno ai 10 milioni di gradi! Guarda un po'!. Nessuno ha mai visto il centro del Sole, ma grazie a qualche esperimento con una semplice scatola sei stato in grado di prevedere come deve essere. Però a differenza della nostra scatola il Sole non ha un coperchio. È la gravità che impedisce al suo gas di lasciare la superficie. Però hai visto che la forza di gravità sulla sua superficie è `solo' 28 volte la gravità sulla Terra. Ricordi poi l'esperimento del cannone? Se riesci a sparare un proiettile a velocità abbastanza alta esso si perde nello spazio per sempre. Per la Terra questa velocità è circa 40 mila km/ora, mentre per il Sole è maggiore di 2 milioni di km/ora. È una velocità molto alta, ma può capitare che una particella riceva una spinta molto forte e lasci il Sole, perché anche la temperatura e quindi il moto di agitazione sono molto grandi. In effetti si calcola che il Sole perda 20 milioni di miliardi di chilogrammi all'anno! Un imbuto grande quanto la Terra alla nostra distanza raccoglierebbe 36 milioni di chilogrammi di Sole in un anno. Questa perdita di massa dal Sole viene chiamata vento solare. È una perdita di massa enorme per noi, ma confrontata con la massa del Sole non è gran che. A questo ritmo, ci vorrebbero 100 mila miliardi di anni per consumarlo tutto! Come il Sole, anche tutte le altre stelle perdono massa tramite questo meccanismo di perdita di singole particelle che viene chiamato vento stellare.
Ma il Sole non perde solo massa. Emette anche radiazione, la maggior parte sotto forma
di luce visibile. La radiazione trasporta energia da un luogo all'altro. Quindi il Sole
allontana da sé continuamente parte della propria energia. Visto che già conosci la
distanza della Terra dal Sole puoi sfruttarla per calcolare la quantità di luce emessa
dal Sole. Ora puoi sfruttare la legge dell'inverso del quadrato. Passando dalla lampadina al cartoncino la luminosità diminuisce proporzionalmente alla distanza tra i due al quadrato. Lo stesso accade alla luce del Sole che diminuisce della distanza tra la Terra e il Sole, elevata al quadrato. Allora il rapporto tra la luminosità del Sole e quella della lampadina è uguale alla distanza Sole-Terra al quadrato divisa per la distanza lampadina-cartoncino al quadrato. Come sai, la distanza Terra-Sole è di 149.600.000.000 metri, dunque la frazione viene circa 38 seguito da 23 zeri! È un numero grande, ma quanto grande? Per fartene un'idea, pensa che in un secondo il Sole emette una quantità di energia che è quasi 2 miliardi di volte più grande dell'intero consumo di energia elettrica in Italia nel 1961. Dalla luce del Sole possiamo ricavare un'altra importante informazione. Possiamo esaminare il suo spettro e ricavare la composizione della nostra stella in base alle righe di assorbimento che si vedono sovrapposte al continuo luminoso. Dopo aver lasciato la fotosfera fotosfera (cioè lo strato di gas da dove la radiazione viene liberata nello spazio), la luce del Sole attraversa gli strati di gas sovrastanti meno densi (l'atmosfera). Questi strati assorbono solo un certo insieme di frequenze dipendente dagli atomi che li costituiscono e riemettono questa radiazione in tutte le direzioni. Il risultato netto è che parte di questa radiazione viene distolta dal cammino verso di noi, e quindi l'intensità della luce in queste frequenze risulta diminuita. Con strumenti adatti potresti vedere che la striscia di luce dell'esperimento della penna è in effetti solcata da righe verticali scure. Ogni elemento chimico è in grado di assorbire un numero di frequenze caratteristico, che rappresenta la sua "firma". Se questa firma viene riconosciuta nello spettro del Sole allora si può affermare che quell'elemento è presente nell'atmosfera. La quantità di energia sottratta dipende poi dall'abbondanza dell'elemento chimico. Esaminando la posizione e l'importanza relativa delle righe dei diversi elementi chimici si può ricostruire la composizione dell'atmosfera solare. Si è trovato che un chilo di Sole contiene circa 3/4 di idrogeno, circa 1/4 di elio e circa 2/100 di tutti gli altri elementi. Visto che il Sole è un corpo isolato nello spazio, la sua grande produzione di energia deve avvenire a spese di se stesso. In che modo? Gli atomi di gas dentro il Sole si muovono molto velocemente e si urtano con violenza. Nel centro del Sole, dove la temperatura è maggiore, gli urti possono far sì che due o più atomi di idrogeno si fondano in un atomo più grande di elio. Tuttavia, la massa del nuovo atomo è leggermente più piccola della somma delle masse degli atomi prima della fusione. La differenza di massa è stata trasformata in energia, parte della quale serve per sostenere il peso della stella, mentre il resto viene emesso sotto forma di luce. È un po' come quando un pezzo di legno brucia: la luce viene emessa a spese della sua massa, che si consuma (infatti la cenere che resta ha una massa molto minore del pezzo di legno originario). Lo stesso succede al Sole: esso emette luce consumando una parte della propria massa. Questo processo in cui due atomi più "piccoli" si fondono per dare origine ad un atomo più "grande" prende il nome di fusione nucleare. Per riassumere. Il Sole è una sfera di gas, ed è il corpo di massa maggiore nel Sistema Solare. Al suo interno si sviluppano una temperatura e una pressione eccezionali, necessarie per controbilanciare il suo stesso peso. La pressione è un effetto del moto di agitazione delle particelle del gas (atomi), il quale è misurato dalla temperatura. Al centro del Sole questo moto è talmente violento che provoca la fusione delle particelle in particelle più pesanti con produzione di energia. L'energia viene liberata sotto forma di luce sulla superficie del Sole (che viene detta fotosfera). La luce illumina tutti gli altri corpi del Sistema Solare. La luce trasporta energia dal corpo che la emette al corpo che la assorbe. La temperatura che abbiamo sulla Terra è dovuta al fatto che la Terra assorbe la luce del Sole e la trasforma in calore. Non ci sono altre sorgenti di luce nel Sistema Solare. Il fatto che i moti delle stelle siano estremamente più piccoli dei moti dei pianeti significa che esse si trovano a distanze molto più grandi. Potrebbero allora essere altre sfere di gas simili al Sole? Ora sai quant'è la luminosità del Sole, e con la legge dell'inverso del quadrato della distanza puoi calcolare quanto diminuirebbe se tu potessi spostarlo ad una certa distanza. Dunque per capire cos'è una stella devi imparare a misurare le distanze oltre il Sistema Solare. Prima di affrontare questo compito puoi rilassarti guardando alcuni filmati che ti mostrano in modo intuitivo alcuni aspetti del Sole.
I filmati ti mostrano bene l'aspetto del Sole. In quanto gassoso il Sole non ha una superficie solida, quel che tu vedi è la sua fotosfera, cioè lo strato di gas da dove la radiazione viene liberata nello spazio. Questo gas è soggetto a vari fenomeni che nei filmati sono evidenziati. Anzitutto si vede la granulazione della fotosfera, che appare come costituita da un insieme di zone separate. Questo fenomeno è causato dal moto turbolento delle diverse celle di gas che risalgono la superficie del Sole. In una pentola che bolle puoi osservare un fenomeno analogo. Sovrapposte a questi granuli (che hanno dimensioni tipiche di qualche centinaio di km) ci sono aree brillanti e scure più estese. Le prime vengono chiamate facole e le seconde macchie solari Il colore più o meno brillante è legato alla temperatura, che è più alta della media nelle facole, e più bassa nelle macchie solari. Si è scoperto che le macchie solari sono connesse a zone dove i campi magnetici del Sole sono più intensi. Le macchie solari sono costituite da una zona a circa 5000 gradi che circonda una zona centrale a circa 4000 gradi, contro una temperatura media della fotosfera di circa 5800 gradi. Le macchie solari vanno dalle dimensioni di un granulo fino alle dimensioni della distanza Terra-Luna. Esse si muovono mettendo in evidenza la rotazione del Sole, che avviene in circa 25 giorni all'equatore e in circa 34 giorni vicino ai poli. A differenza dei corpi solidi il periodo di rotazione del Sole non è quindi lo stesso per tutti i punti. In certe condizioni dai campi magnetici della macchie solari si liberano improvvisamente grandi quantità di energia e viene emesso nello spazio un grande numero di particelle cariche. Dopo circa un giorno queste particelle raggiungono la Terra e vengono catturate dai poli magnetici dando origine alle aurore polari. Durante le eclissi totali di Sole si può vedere la cromosfera di colore rosato. Il suo colore è dovuto all'emissione dell'idrogeno ed è visibile subito prima che la Luna copra totalmente il Sole e subito dopo. Le eclissi totali permettono anche di vedere le protuberanze e la corona solare. Le protuberanze quiescenti sono colonne di gas che formano archi lunghi fino a 100.000 km e che possono durare mesi, ma vi sono protuberanze eruttive che durano poche ore. Quando sono viste contro la fotosfera le protuberanze vengono chiamate anche filamenti. La corona solare è costituita da gas rarefatto che durante le eclissi totali si manifesta come una luminosità di dimensioni confrontabili a quelle del Sole. Ora hai appreso le caratteristiche più importanti del Sole, e queste ti serviranno per
scoprire le stelle!!. Last modified: Dec 16, 1997 |
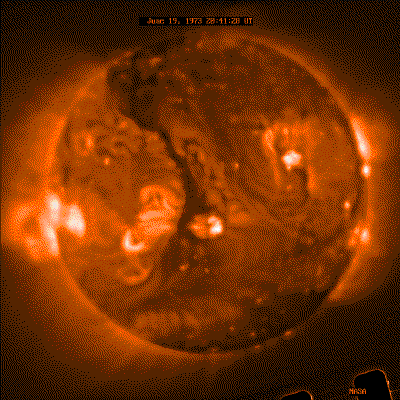
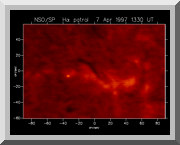 Il filmato
mostra il brillamento solare del 7 aprile 1997. La durata reale dell'evento è di circa 2
ore e mezza. Un brillamento solare è connesso all'improvviso rilascio di energia da parte
del campo magnetico del Sole. La temperatura del materiale gassoso è probabilmente di 10
milioni di gradi. (Cortesia del National Solar Observatory/Sacramento Peak)
Il filmato
mostra il brillamento solare del 7 aprile 1997. La durata reale dell'evento è di circa 2
ore e mezza. Un brillamento solare è connesso all'improvviso rilascio di energia da parte
del campo magnetico del Sole. La temperatura del materiale gassoso è probabilmente di 10
milioni di gradi. (Cortesia del National Solar Observatory/Sacramento Peak) 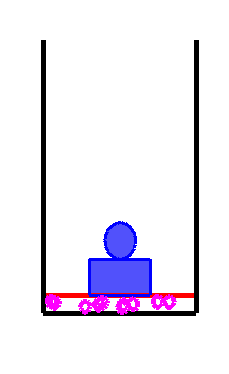 Immagina allora una situazione come quella della figura. Hai una scatola con un coperchio
mobile, tenuta chiusa da un peso. Dentro la scatola ci sono delle particelle. Fai alcuni
esperimenti cliccando qui sotto.
Immagina allora una situazione come quella della figura. Hai una scatola con un coperchio
mobile, tenuta chiusa da un peso. Dentro la scatola ci sono delle particelle. Fai alcuni
esperimenti cliccando qui sotto. 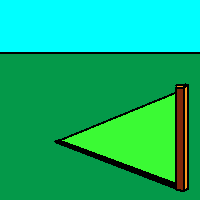 Puoi
farlo confrontandola con quella di una lampadina di luminosità nota, ad esempio 100 Watt.
Anzitutto prepara un cartoncino bianco inclinato in modo che i raggi del Sole siano
perpendicolari al cartoncino. Per farlo puoi fissare un bastone perpendicolare al suolo e
ritagliare un triangolo rettangolo che abbia un lato uguale alla lunghezza del bastone e
l'altro uguale alla sua ombra.
Puoi
farlo confrontandola con quella di una lampadina di luminosità nota, ad esempio 100 Watt.
Anzitutto prepara un cartoncino bianco inclinato in modo che i raggi del Sole siano
perpendicolari al cartoncino. Per farlo puoi fissare un bastone perpendicolare al suolo e
ritagliare un triangolo rettangolo che abbia un lato uguale alla lunghezza del bastone e
l'altro uguale alla sua ombra. 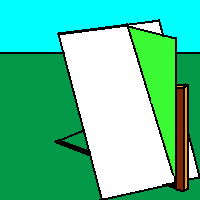 Poi prendi il triangolo e mettilo come nella figura. In questo modo
appoggiando il cartoncino bianco come nella figura ce l'hai perpendicolare ai raggi
solari. A questo punto avvicina la lampadina e misura a che distanza dal cartoncino la
lampadina lo illumina con la stessa intensità del Sole. La distanza dovrebbe essere più
o meno 7,6 centimetri, cioè 0.076 metri.
Poi prendi il triangolo e mettilo come nella figura. In questo modo
appoggiando il cartoncino bianco come nella figura ce l'hai perpendicolare ai raggi
solari. A questo punto avvicina la lampadina e misura a che distanza dal cartoncino la
lampadina lo illumina con la stessa intensità del Sole. La distanza dovrebbe essere più
o meno 7,6 centimetri, cioè 0.076 metri.